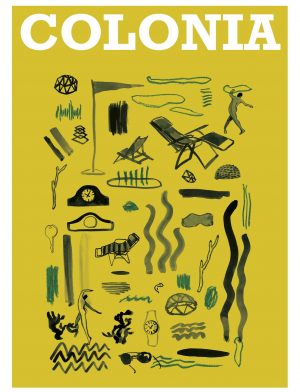 Con Colonia dei Muta Imago prosegue la proposta teatrale del Florian Metateatro all’insegna dello spettacolo che è più evento, esperienza da vivere e partecipare che non una performance a cui assistere.
Con Colonia dei Muta Imago prosegue la proposta teatrale del Florian Metateatro all’insegna dello spettacolo che è più evento, esperienza da vivere e partecipare che non una performance a cui assistere.
La riflessione è tanto più vera nel caso di Colonia, che rientra nel novero di quei lavori “di confine” tra un genere e l’altro, a cui i Muta Imago ci hanno abituato lungo il loro ormai più che decennale percorso di ricerca artistica. Per essere precisi, Colonia è una installazione e dunque lo spettatore non si misura con la prova di uno o più attori. Anzi, gli spettatori, nuovamente per essere precisi, quasi puntigliosi, dato che l’ingresso per l’installazione è limitato a due persone per volta: congiunti e non, conoscenti o perfetti sconosciuti, bisogna prenotarsi ad uno dei numerosi turni in cui la performance si replica durante ogni giornata di programmazione.
Il primo dato è dunque questo: Colonia presenta delle “regole” da seguire, come una terapia o come un gioco. E come il teatro stesso: anzi, con l’installazione accade che in teatro più si sottrae la scena (e con essa l’azione, la parola, la fisicità dell’attore), tanto più si svela il sistema di regole che restavano nascoste sullo sfondo del teatro, proprio come i fili del puparo o gli ingranaggi di un carillon.

E qui veniamo lesti al secondo dato: le caratteristiche estetiche dell’installazione. Proprio perché viene sottratta la performance di scena, l’artista che crea una installazione si concentra su di un progetto che preveda ogni minimo dettaglio materiale di una creazione che poi dovrà essere autonoma nell’esprimere se stessa con il pubblico. La “colonia” dei Muta Imago (è forse questo l’enigma celato nel titolo? siamo i nuovi, auspicati colonizzatori di una territorialità ancora priva di mappatura?) ci appare come una navicella spaziale o forse un satellite. Ricorda persino lo “scheletro” di un pianeta con la sua forma sferica. ottenuta però tramite una struttura geometrica fatta di linee, angoli, spigoli.
Chi ha la ventura di partecipare a Colonia in una delle date di Pescara, ha modo di cogliere in maniera quanto mai netta un tratto caratteristico dell’installazione: il contrasto, anzi la convivenza tra uno slancio avveniristico ed una fuga dalla modernità. Felicissima in questo senso l’intuizione del team Florian: l’installazione prende infatti corpo all’interno dell’amplissimo spazio naturalistico che circonda il teatro d’Annunzio, sormontato dalle membra altissime di pini numerosi ed annosi.
La presenza della natura è prorompente, cinge la strana cupola caricandola di interrogativi e significati criptici. Trasformandola dunque in un “geroglifico” da decodificare.

Per un istante, torna prepotente alla memoria Solaris di Tarkosvkij: un’immagine, un frame, un dettaglio, oppure una suggestione solo vaga e generale, come un umore di fondo. Ma se invece fossimo noi ad essere in un film – il nostro arrivo al Teatro D’annunzio, il lungomare pescarese, l’ingresso nella pineta prima e nella cupola poi, il velo di quiete intorno a colorare ogni gesto di liquida, remota sacralità – se tutto questo fosse già parte della creazione artistica, allora una colonna sonora perfetta sarebbe Hold on to me dei Placebo, con quella sospensione tra “lessico famigliare” e filosofia minima, quesiti di ordinaria quotidianità ed improvvisa lettura messianica sul senso di ogni cosa.
E così avviene, in sospensione. Entriamo nella cupola, con il nostro compagno di viaggio lì accanto a noi, forse a sottolineare proprio questo. Stiamo per vivere un dislocamento, ma non siamo soli, non è frutto della nostra immaginazione o di una forma di alienazione individuale. Abbiamo un testimone.
Nella cupola troviamo ad attenderci due invitanti chaise longue che immediatamente si proiettano negli strati profondi del nostro cervello e come una iniezione rilasciano endorfine. Quella coppia di utensili pieghevoli si smaterializza e si aziona istantaneamente come una icona digitale ad esplodere una catena di immagini mentali: un hotel, una spa, una spiaggia, un giardino. E poi: riposo, occhi socchiusi, pausa, dimenticanza intenzionale. Fino a farsi strada sul palato (sete, aroma dolciastro, una bibita fresca) e nel corpo (un massaggio alla base del collo), per poi tornare idea (desiderio di abbandono, rilascio della sorveglianza).
Ma il tutto dura meno di un secondo: il tempo si espande e si ripiega. Il tempo non esiste, ma si ripete, ciclico. Chi ha la ventura di partecipare a Colonia in una delle date pescaresi, oltrepassa sui binari affettivi l’ultimo varco di realtà: le “istruzioni per l’uso” viaggiano sui toni del garbo unico che ha l’eloquio di Massimo Vellaccio, co-direttore, co-fondatore, factotum del Florian.
Mentre mi adagio sul lettino, non posso non riflettere su di una prima volta quasi assoluta: il teatro di norma non è un luogo comodo, men che meno quello di ricerca, che si ciba di posti in piedi o a terra o di tappetini da yoga quasi come di un ingrediente indispensabile.
Per contro, stordito da questo surplus di delicatezze, lo sguardo fisicamente orientato verso il cielo cattura meccanicamente un’istantanea come l’ultimo sguardo prima della narcosi: le dita dei pini come un frangisole per l’azzurro immenso dell’estate. La stele dannunziana, totemica e apparentemente leggerissima. Non c’è dubbio, questa città è proprio diversa vista da quaggiù.
Qualcuno alle mie spalle mi copre gli occhi con una benda dal peso impalpabile, ma del tutto impermeabile alla luce ed alla mia vista. Indosso un paio di cuffie stereofoniche. Preceduto dalle intermittenze e dai cortocircuiti della mia psiche individuale, il viaggio ora ha veramente inizio.
Tutta sbilanciata sull’ascolto, la mia percezione va disperatamente alla ricerca di appigli come un corpo in mare, che se non trova uno scoglio a cui reggersi cerca almeno un punto all’orizzonte verso cui dirigersi. Così, ogni dettaglio diventa un significato in potenza, alla stregua di un capello sul pavimento per l’occhio dell’investigatore. Ogni rumore, ogni fruscio viene scandagliato dalle energie generosissime dei muscoli, disimpegnati per una volta dal compito di sorreggerci in una qualche posizione. La traccia audio viene perlustrata in tutti i suoi livelli: i suoni in primo piano, quelli sullo sfondo, quelli intermedi. La partitura sonora messa a punto da Riccardo Fazi non contiene la minima musicalità (se non intesa in senso primario e materico), di certo rifugge da ogni intento melodico, armonico, perfino ritmico, in quanto che rifugge da ogni schematismo di riferimento.
Me ne accorgo solo dopo qualche minuto: è una gara con la mia razionalità. All’inizio ascolto i suoni cercando di capire se l’artista mi voglia porgere tracciati da percorrere o tracce da seguire, poi finalmente concludo che non ha questo profilo la terra su cui mi trovo, la sua sismicità. Non va percorso questo terreno, ma seguito per scivolamento, dentro i viluppi tutti interiori prodotti dal suono a partire da una feritoria che lo spettatore decide quando, quanto e come incidere sul proprio epidermide: la barriera tra sé ed il mondo, la bocca del linguaggio sensoriale.
E così la durata della partitura (per inciso, 20 minuti circa) non persegue uno sviluppo narrativo o di altro genere, se non quello di un procedimento alchemico tutto mirato al raggiungimento di un’unica soglia: il rilascio fisiologico nella resistenza dello spettatore (anch’essa fisiologica).
È curioso che, per una installazione sonora, da vivere ad occhi chiusi, mi sovvenga per la seconda volta una suggestione cinematografica. Penso a David Lynch, a certi suoi enigmi sinuosamente fini a se stessi, pure profondità da esplorare a braccia aperte fin dove l’estensione dei polmoni concede, diversa per ogni nuotatore, per poi tornare sulla terra ferma. Cosa aggiungerebbe la presenza di una spiegazione, di un senso razionalmente riconducibile, metricamente misurabile, scientificamente ponderabile? Per quello basta un cruciverba o un rebus sotto l’ombrellone.
Ed in effetti un enigma rimane. Il viaggio sonoro è preceduto da una breve introduzione, sempre in audio, pronunciata dalla voce dello stesso Riccardo Fazi ed accompagnata da una citazione sulla fisica quantistica. In particolare, sulla sua conclusione più feconda: “il tempo non esiste”.
E “la vita non basta”, aggiungerebbe Pessoa, ed è per questo che arte e spiritualità continuano ad indagare oltre i confini del noto, ad onta di ogni gradino compiuto dalla società della conoscenza, della scienza e dell’informazione.
Orbene, il viaggio sonoro lungo cui i Muta Imago ci conducono mira a creare un mood specifico, a suscitare una sensazione di oltretempo e di oltrespazio? A tradurne il concetto in termini di percezione sensibile?
Oppure, la partitura mira al puro vuoto, ad aprire in noi uno spazio aspecifico, staccandoci dal nostro sistema di certezze e convenzioni (la cosiddetta comfort zone)?
Che cos’è Colonia? La proiezione di un ologramma inedito per forme e colori, oppure una tela bianca, denudata finalmente dalla parola raziocinante, su cui ognuno di noi imprimerà la propria impronta?
—–
CREDITS
“COLONIA”
Installazione/performance per due spettatori alla volta
Autore: Muta Imago (Roma, Bruxelles)
Ideazione: Glen Blackhall, Riccardo Fazi,Claudia Sorace
Partitura sonora: Riccardo Fazi
Cupola geodetica realizzata da Maria Elena Fusacchia
***
Repliche dal 26 luglio al 1° agosto 2020
Spazio Pineta del Teatro D’Annunzio, Lungomare Cristoforo Colombo, 122Pescara
Turni: ore 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Organizazione Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale
Stagione 2019-2020







